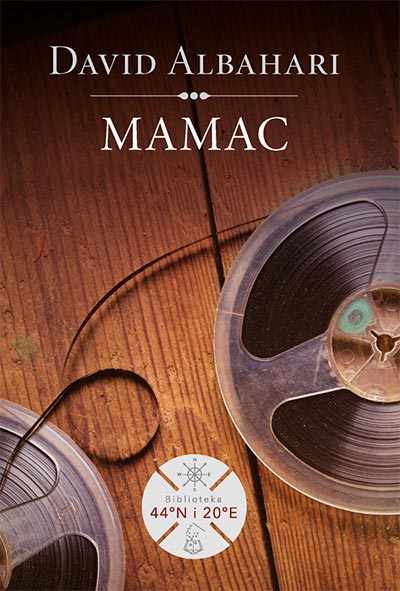Marco Biasio
Quando David Albahari dà alle stampe Mamac (“L’esca”, 2008), romanzo premiato con il prestigioso premio letterario NIN, corre il 1996, un anno chiave per la storia recente dei giovani stati nazionali sorti dopo il sanguinoso disfacimento della Repubblica socialista jugoslava. La controffensiva militare a tutto campo lanciata nell’agosto 1995 e divenuta tristemente nota all’opinione pubblica come Operazione Tempesta (Operacija Oluja) ha permesso all’esercito croato di riguadagnare i territori occupati dall’autoproclamata Repubblica Serba di Krajina, volgendo in proprio favore le sorti della Guerra croata d’indipendenza e, per diretta conseguenza, avvicinando la fine del conflitto in Bosnia ed Erzegovina, la cui fase terminale è segnata dalla cruenta pulizia etnica di Srebrenica e dalla risposta armata della NATO contro l’esercito della Repubblica Serba. Scosse dall’escalation di violenza radicale esibita dagli opposti schieramenti e ormai sature dell’opportunismo politico di un establishment corrotto, autocratico e disposto ad ogni compromesso pur di tenere salde le redini del potere, le opinioni pubbliche serba e croata manifestano tutto il proprio scontento con una serie di dimostrazioni pacifiche solo in parte contrastate dalle forze dell’ordine. A tutto questo Albahari, apprezzato scrittore d’origine ebraica attivo da una ventina di anni nel campo della prosa romanzesca e del racconto breve, non può partecipare direttamente: nel 1994 ha infatti lasciato Belgrado e si è trasferito con la famiglia a Calgary, in Canada. Non è solamente l’atto inaugurale della seconda e più prolifica fase dell’attività letteraria di Albahari: è una cesura profonda tra una vita dell’al-di-qua, in uno spaziotempo finito in pezzi e andato forse perduto per sempre (similarmente al bosanski lonac che lo Zlaja delle Marlboro di Sarajevo di Miljenko Jergović cucina per la compagna Jelena, una specialità gastronomica che si fa assieme metafora geopolitica) e una vita dell’al-di-là, un luogo fisico e dell’anima in cui l’individuo atomizzato non può far altro che vagare in(de)finitamente, libero forse dalle pastoie sovrastrutturali (culturali, ideologiche) della precedente quotidianità, ma al contempo privo di affidabili punti di riferimento.
Sull’importanza di Mamac come exemplum di letteratura dell’esilio volontario (la definizione viene ripresa da uno studio di Ljiljana Banjanin) e sulla sua architettura tecnica, in particolar modo sugli aspetti formali della scrittura adottata da Albahari e sulla rappresentazione di una narrazione plurivoca che mescola e incrocia continuamente punti di vista interni ed esterni, la critica serba e internazionale ha avuto modo di scrivere molto (a titolo esplicativo si ricorda, in questa sede, un solo recente contributo di Mihajlo Pantić). È difficile individuare il ruolo preponderante di “un” protagonista univoco a discapito degli altri personaggi-satellite, che interagiscono a vicenda con la loro fisicità corporea (l’amico canadese Donald) o la loro perturbante dimensione mentale (le figure, irreali eppure stranamente tangibili, dei genitori scomparsi dell’io narrante): nello scarto tra il fattuale e il rievocato, tra la realtà e il ricordo, tra il passato e il futuro, tra l’impotenza del segno linguistico e il fenomeno cui si riferisce s’insinua ed agisce un dualismo manicheo, forse espressione di un ego sfaccettato che proietta al di fuori di sé fantasmi di un’esistenza precedente, come sembra suggerire Danijela Marot Kiš (p. 477). Particolarmente importante e articolato, a tal proposito, è il peso ascritto alla voce femminile, che nell’arco dell’intero romanzo viene sublimata da una vecchia registrazione su nastro della madre del protagonista. È una voce che viene da un passato che, faulknerianamente, non è mai davvero passato: una traccia lasciata su un magnetofono seppellito per anni in scatole di cartone impolverate, l’unico legame che il narratore condivide ancora con il padre scomparso sedici anni prima e di cui la madre, sotto richiesta del figlio, ricostruisce dopo poco tempo la storia. Ma il tramite materno restituito da un supporto fonografico fuori moda non è semplicemente l’ultima, indiretta prova di appartenenza ad un rod, una “stirpe”, e una vera, una “fede” (ebraica), entrambe disintegratesi sui titoli di coda della Jugoslavia post-titina: è anche, e soprattutto, il cordone ombelicale che ricostruisce la dimensione linguistica del narratore, jezik nella duplice accezione di “lingua” e “popolo”, la riaffermazione di un’identità divenuta apolide che, per di più, nel nuovo paese è costretta a scontrarsi con differenze culturali pressoché incolmabili, con una visione del mondo e della storia agli antipodi (“Non avevo più un paese, ero rimasto senza madre, mancava solo che la lingua si consumasse del tutto e allora sarei rimasto senza niente”, p. 123). In un certo senso, allora, lo spettro della madre diviene portavoce di un romanzo familiare, i cui orizzonti – e i cui destini – combaciano quasi perfettamente con quelli della madrepatria jugoslava. Più precisamente ancora, se è di un padre incorporeo che si ricompone l’esistenza terrena, è pur sempre il racconto della madre a fornire coerenza narrativa e coordinate temporali alla storia, è attraverso l’alternanza fra i pieni della sua voce monologante e i vuoti dei suoi silenzi improvvisi che si ricostruiscono i contorni di un’epopea di dolore lunga cinquant’anni e senza apparente lieto fine: l’antisemitismo, i lager nazisti, le crudezze di un primo socialismo lontanissimo dalle fascinazioni pop art degli anni ’60 raccontate con precisione da Radina Vučetić. Non esiste la patria scomparsa senza una matria sommersa, un rapporto necessitante a cui allude da subito anche lo stesso titolo del romanzo (pur essendo derivato sostantivale del verbo mamiti, “adescare”, è evidente come mamac richiami immediatamente alla mente mama, termine affettuoso della cerchia familiare).
Elemento fondamentale della narrazione materna è il tempo o, per meglio dire, la dimensione temporale del racconto, il modo in cui fluisce e in cui, in quanto registrazione fisica, può essere extradiegeticamente accelerato, rallentato, fermato, invertito, intervallato con altri piani narrativi. Il monologo femminile è monologo di tempo e di spazio in quanto tempo, composto di parole registrate che variano impercettibilmente ad ogni loro riproduzione: e poiché Mamac è madre ed esca allo stesso momento, ovvero registrazione di una voce narrante e racconto attorno alla registrazione di una voce narrante, va da sé che nella narrazione materna si nasconde un congegno formale autonarrativo attraverso il quale il figlio può riconoscere sé stesso, come esemplifica alla perfezione il seguente passaggio:
“Lo scrittore è come il filtro della macchina da caffè, riteneva Donald, e deve, proprio come un filtro, trattenere l’inutile sedimento e far passare solo il succo, il liquido, il fluido che è la sostanza. Se lo scrittore si mette a spiegare, ha continuato, allora rimane nel sedimento, non riesce ad aver ragione del filtro di carta. […] Un’altra volta ha esposto in lungo e in largo la sua teoria secondo la quale la differenza fra un’avanzata e un’arretrata concezione del mondo consiste proprio nel rapporto verso i fondi di caffè, perché i popoli arretrati nella tazzina versano anche i fondi. […] Se me lo avesse detto a Belgrado, l’avrei lasciato seduto lì e me ne sarei subito andato, ma in America settentrionale uno si abitua a teorie del genere. In questo genere di cose un nordamericano è più testardo di mia madre. Lei sicuramente non sarebbe stata così longanime come me. Per lei, originaria della Bosnia, bere il caffè rappresentava il momento in cui, dimenticando le preoccupazioni quotidiane, un uomo si accosta al divino, si siede ai piedi del Signore. Del resto, avrebbe detto, nei fondi è contenuto il futuro, e bere quel caffè, con i fondi, significava l’unione di tutti i segmenti temporali, ossia, uno che beve il caffè senza fondi esiste solo nel presente.” (p. 70)
L’astrazione del presente si fa a tal punto irraggiungibile per il figlio, disancorato dalla matria e dalla lingua, incapace di descrivere la nuova quotidianità con gli strumenti culturali e linguistici a disposizione, che il suo unico concreto tentativo di affrancarsi dalla propria atavica condizione – sottoporre il manoscritto del romanzo che stiamo leggendo all’amico Donald – fallisce e viene inghiottito dal buio, come già acutamente notato da Zoran Milutinović (p. 22). L’assenza della madre, voce incorporea nascosta per anni dietro i tomi del Vocabolario della lingua serbo-croata editi dall’Accademia, non può essere colmata: “[…] Una volta che qualcosa se ne è andato, se ne è andato per sempre” (p. 106), come lei stessa confessa al figlio sul letto di morte. Per il figlio non esiste nemmeno più il conforto di un magnetofono che ne raccolga le ultime impressioni, le note a margine di un puzzle esistenziale cui manchino diversi pezzi.
Bibliografia:
David Albahari, Mamac, Beograd, Narodna knjiga, 1996 (L’esca, trad. Alice Parmeggiani, Rovereto, Zandonai, 2008).
Ljiljana Banjanin, Due volti dell’esilio nella letteratura serba: Crnjanski e Albahari, in Giovanna Moracci, Alberto Alberti (ed.), Linee di confine. Separazioni e processi di integrazione nello spazio culturale slavo, Firenze, Firenze University Press, 2013, pp.183-197. Disponibile online al link: https://iris.unito.it/retrieve/handle/2318/142672/573676/Lj.%20Banjanin%2C%20%20Due%20volti%20dell%27esilio%20nella%20letteratura%20serba.pdf (ultima consultazione: 21/03/2021).
Danijela Marot Kiš, Sjećanje na život: pripovijedanje i pamćenje u romanu Mamac Davida Albaharija, in “Slavistična revija”, Let. 65, Št. 3 (julij–september, 2017), pp. 475-486. Disponibile online al link: https://srl.si/sql_pdf/SRL_2017_3_04.pdf (ultima consultazione: 21/03/2021).
Zoran Milutinović, The Demoniacism of History and Promise of Aesthetic Redemption in David Albahari’s Bait, in “Serbian Studies”, Vol. 19, No. 1 (2005), pp. 15-24. Disponibile online al link: https://drive.google.com/file/d/1uPEXo9ivItzF9Rmi7Iahn4E2B_aS187w/view (ultima consultazione: 21/03/2021).
Mihajlo Pantić, Prozni svet Davida Albaharija, in Veroljub Vukašinović (ed.), Savremena srpska proza. Zbornik 26. Književnih susreta, Trstenik, 2010.
Radina Vučetić, Coca-Cola Socialism: Americanization of Yugoslav Culture in the Sixties, Budapest-New York, CEU Press, 2018.
Apparato iconografico:
[Immagine_1]:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/David_Albahari_auf_dem_Blauen_Sofa.jpg
[Immagine_2]: https://www.delfi.rs/knjige/166871_mamac_knjiga_delfi_knjizare.html