Martina Cimino
Splendenti così chiare
fin sul far del giorno –
chi accompagnate,
mie lanterne?
Chi proteggete,
incoraggiate,
illuminate,
mie lanterne?
***
[…] I peschi divini
dei giardini delle Esperidi […]
(p. 113)
Al pari delle Esperidi, Marina Cvetaeva è considerabile custode di una dimensione immortale dell’esistenza. Eppure, contrariamente a quanto si potrebbe essere indotti a pensare, Cvetaeva nel corso della sua vita fronteggia una costante condizione di perdita, nella quale si inscrivono i suoi Ultimi versi, editi in italiano da Voland nell’agosto del 2021 con traduzione a cura di Pina Napolitano.
Link del libro: https://www.voland.it/libro/9788862434270
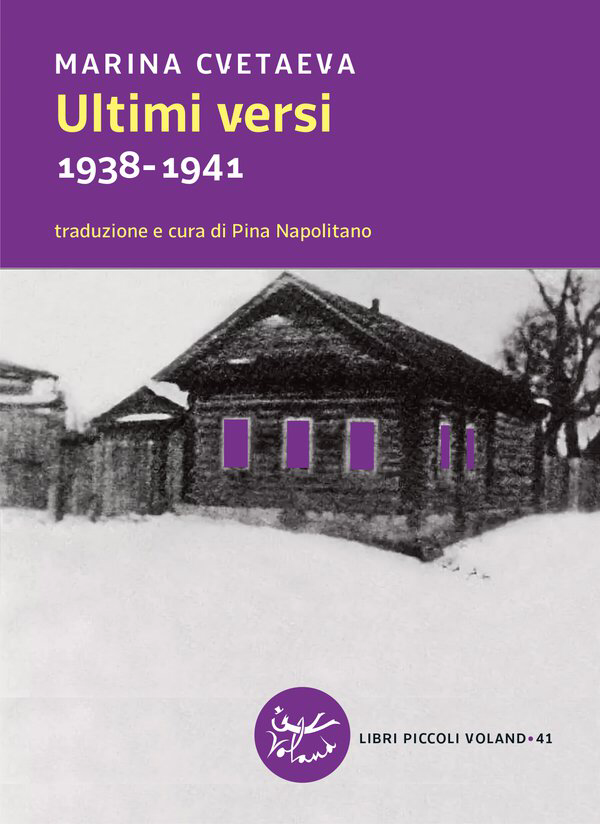
Con il titolo del volume, come specificato nella ricca introduzione, si identifica quella produzione poetica che intercorre tra il 1938 e il 1941, anno in cui la poetessa pone fine alla propria vita impiccandosi. Il 1938 è un anno fondamentale nella sua biografia in quanto ultimo anno di emigrazione prima del ritorno definitivo in Russia. In quell’anno Cvetaeva è a Vanves, sobborgo di Parigi, in cui vive con il figlio Mur (Georgij) mentre il marito Sergej Efron, agente sovietico, e la figlia Alja hanno già fatto ritorno a Mosca. Convivendo con un senso di isolamento intellettuale e personale dovuto all’ostilità della comunità di emigrati russi nei suoi confronti, al peso della separazione si accompagna il tormento generato dalla scelta di tornare in patria per raggiungere i propri cari. Scelta che evidenzia l’importanza di una sfumatura dal carattere più specificatamente politico che rivela non solo l’amore di Cvetaeva per chi soccombe davanti al potere ma anche il distacco tra la propria esistenza reale e quella onirico-letteraria. Che si tratti dei Bianchi, dello zar o della Boemia, l’attualità politica ha da sempre interessato la poetessa, tanto che al 1917 risale la composizione del primo dei due cicli di versi politici, Lebedinyj stan (“Il campo dei cigni”, 1917-1920). Con l’acuirsi della gravità della situazione internazionale dovuta all’annessione della regione dei Sudeti da parte della Germania hitleriana e la conseguente occupazione della Cecoslovacchia nel marzo 1939, nasce infatti l’ultimo dei suoi cicli di poesie Versi per la Boemia, presentato nel volume.
Alla Boemia, unica terra che l’autrice arriva a considerare come propria patria, è assimilata quella dimensione religiosa che, sottolineata dalla paronomasia Bogova! Bogemija (Di Dio! Boemia!, p. 72), ripropone la dialettica byt (dimensione quotidiana) e bytie (dimensione esistenziale) iscrivibile nella sfera onirico-letteraria in cui Cvetaeva conduce la propria esistenza, per suo statuto inenarrabile. Quest’ultima, lontana da una più basilare definizione di vita, non consiste in uno iato insormontabile tra sogno e realtà o nell’evasione verso mondi fantastici, ma nell’unica possibilità di affermare la propria libertà attraverso un’esecuzione della vita stessa. In cui eseguire la vita, come scrive Serena Vitale nell’introduzione al volume Il paese dell’anima, viene percepito come un compito affidatole da un severissimo maestro a cui, pur non riconoscendo alcuna autorità, non può ribellarsi. Di conseguenza, è in tale esecuzione che si disvela lo statuto stesso della poetica cvetaeviana:
“qualcosa, qualcuno si insedia in te, la tua mano è solo strumento – non di te, di un altro… Io sono sempre stata scelta dalle mie opere per la mia forza, e spesso le ho scritte quasi contro voglia. E arrendendomi – a volte ciecamente, a volte ad occhi aperti, – ubbidivo, cercavo faticosamente con l’udito il compito sonoro già assegnatomi”. (p. 11)
Statuto in cui il bytie corrisponde a quella condizione attiva dell’essere che è il regno delle intenzioni, dei desideri e della libertà che per essere raggiunto fa affidamento a due strumenti: il sogno, “la mia vera vita, senza eventi casuali, tutta fatale, dove tutto si avvera” (p. 53) e il suo corrispettivo diurno, la lettera “… una forma del rapporto ultraterreno” (p. 56).
L’impossibilità di soddisfare i propri bisogni all’interno della sfera quotidiana, travolta dall’intemperie della politica internazionale, la conduce, dunque, a ritrarsi in se stessa e cercare disperatamente di comporre dei versi che non sono destinati a esistere, privandosi in questo modo di quell’affermazione di sé tanto fondamentale da assumere carattere di scongiuro attraverso cui tentare di piegare la realtà. Eppure, sono tentativi blandi che, per quanto condotti con insistenza e cura filologica, producono quasi esclusivamente una serie di frammenti in cui prevale quel processo di idealizzazione che travolge tutti gli oggetti del desiderio cvetaeviano. Oggetti ormai costretti a sottrarsi alle più contingenti richieste e rivelarsi un addio frammentario a ciò che è realmente l’anima.
“Se esiste in questa vita il suicidio, non è lì dove lo si vede, ed è durato non il tempo di premere il grilletto, ma dodici anni di vita” (p. 21).
Miei tanti! Abbeverati
dritto alle radici dell’anima.
Oh, voi in diaspora, compagni dell’anima mia!
Per voi mi tocca soffrire – non
morire […]
Oh, nella dispersione della sorte –
voi ciò che è dell’anima mia!
Miei tanti! Infiniti!
Miei morti ( – tu, vivi!)
Miei lontani! Proibiti!
Di domani – non miei!
Miei mortali! Immortali
voi, per cimiteri! Voi, stormo
di gru – tra le nuvole in cielo…
Oh, voi, che siete nella dispersione
della sorte – dell’anima mia!
Voi, per piazze – per cimiteri –
per carceri – (p. 103)
“Per sei la tavola ho preparato…”
Continuo a ripetere il primo verso,
e a correggere una parola:
– “Per sei la tavola ho preparato”…
Hai dimenticato uno – il settimo.
Sedete tristi in sei.
Sui volti rivoli di pioggia…
Come hai potuto a questa tavola
scordare il settimo – la settima…
Tristi i tuoi ospiti,
ferma la caraffa di cristallo.
Mesti loro, mesto tu,
più mesta di tutti – la non invitata.
Malinconici e cupi,
ah! non bevete e non mangiate.
– Come hai potuto scordare
quanti? Sbagliare il conto?
Come non capire, con quale ardire,
che sei (due fratelli, il terzo – tu stesso,
con tua moglie, tuo padre e tua madre)
diventano sette – se io esisto!
Per sei hai preparato la tavola,
ma con sei non finisce il mondo.
Piuttosto che spauracchio tra i vivi –
uno spettro voglio essere – con i tuoi,
(i miei)…
Timida come un ladro,
oh – senza turbare un’anima! –
al posto non apparecchiato
mi siedo, la settima, non invitata.
Ecco! – ho rovesciato il bicchiere!
E tutto quanto voleva versarsi, –
dagli occhi il sale, dalle ferite il sangue –
dalla tovaglia scorre – sul pavimento.
E non c’è bara! non c’è distacco!
l’incantesimo del tavolo è rotto, ridesta la casa.
Come la morte al banchetto di nozze,
io sono la vita, venuta a cena.
…Nessuno: non fratello né figlio, non marito
nè amico – e tuttavia ti depreco:
– Tu, che hai apparecchiato per sei – anime,
e non mi hai lasciato un posto – in un angolo.
(p. 116)
Bibliografia:
Marina Cvetaeva, Ultimi versi 1938-1941, Roma, Voland, 2021.

