Martina Cimino
Polacco ed ebreo, Isaac Bashevis Singer, premio Nobel 1978, va annoverato tra i grandi autori della letteratura yiddish che mantengono vivo un legame con la tradizione e il paese natale – legame evidente a partire dal matronimico Bashevis adottato come omaggio filiale per distinguersi dal fratello maggiore Israel Joshua Singer –. Spesso associato alla generazione di autori ebrei-americani della New York ebraica con cui intrattiene dei rapporti intellettuali, Singer sceglie di mantenere una posizione di distacco dalla cultura americana, nonostante il suo trasferimento nel 1935. Tale scelta, ricollegabile a quella di scrivere in yiddish sin dall’esordio, deve essere letta in relazione alle vicende narrate. Infatti, il motivo fondamentale è riscontrabile nel fatto che le sue opere potevano essere scritte soltanto nello yiddish della tradizione, in quanto “lingua più ricca del mondo” e unica lingua di cui fosse in grado di estrarre l’essenza e la materia per dare voce a quelle maschere tragiche e ironiche che popolano i suoi lavori. Lo scarso interesse nutrito verso il mondo americano lo conduce a non abbandonare la propria identità e la propria lingua materna, la mameloshen, in quanto, – come testimonia provocatoriamente il suo saggio Problemen fur der yidisher proze in Amerike (“Problemi riguardanti la prosa yiddish in America”) pubblicato sulla rivista “Svive” nel 1943 –, “una lingua che non è insegnata nelle scuole elementari, nelle scuole superiori e nelle università, una lingua che non è usata fra i contadini e nelle industrie, una lingua che non serve per costruire treni e ponti, automobili e aerei, non è di alcun interesse.” Affermazione chiaramente provocatoria intesa a sottolineare la vitalità di questa lingua. Pertanto, come ha scritto Alberto Cavaglion nell’introduzione al meridiano:
“L’idea che Singer coltivava segretamente era quella di conservare alla lingua dei suoi padri un certo qual sapore di arcaicità. Nella sua mente forse sognava un avvicinamento a ciò che era stato, secoli prima, l’aramaico, una lingua morta che proprio grazie alla sua arcaicità aveva saputo ridonare vita e vigore alle correnti mistiche dell’età moderna.”
Il che spiega anche il rifiuto da parte di Singer di narrare gli orrori del nazismo e dell’assunto teorico di Walter Benjamin sulla necessità del silenzio da parte del narratore dopo gli eventi della Shoah. La scelta di narrare si delinea perciò all’interno di un nuovo genere a metà tra finzione e autobiografia, reportage e allegorie che risponde alle convenzioni del realismo ottocentesco.
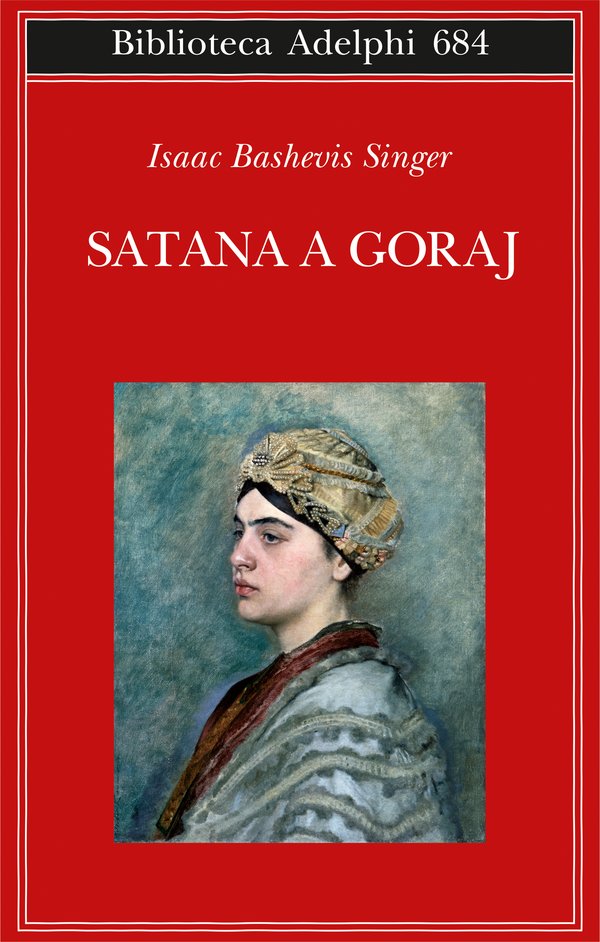
Tutte queste caratteristiche sono evidenti a partire dal suo romanzo d’esordio Der Sotn in Goray (“Satana a Goraj”) pubblicato a puntate sul periodico polacco “Globus” nel 1933 e in volume nel 1935. La vicenda narra la ripresa della vita del paesino di Goraj, nel voivodato di Lublino, dopo lo sterminio degli ebrei perpetrato dai tatari di Crimea, dai contadini rivoltosi e dai cosacchi di Bogdan Chmel’nitskij nel 1648. Partendo, dunque, da un fatto storico, Singer offre un quadro di disgregazione dello shtetl (borgo ad alta densità di popolazione ebraica) ebraico nella metà del Seicento, quando iniziano a diffondersi dicerie attorno alla venuta del sedicente Messia Shabbatay Tzevi (1626-1676), dovute alla precedente catastrofe. Nonostante l’argine che Rabbi Benish, capo della comunità, tenta di innalzare a salvaguardia della legge religiosa impedendo lo studio della Cabbala, l’ansia millenaristica pervade i membri della comunità di Goraj, che cedono al peccato e si lasciano travolgere dal male in un’allucinazione collettiva. Allucinazione oscura e dissacrante che, attraverso i tratti delle storie di possessione demoniaca che attraversano l’Europa ashkenazita, presenta il punto di contatto con le complesse cosmologie cabbalistiche che si svuotano di ogni sacralità e lasciano il posto a una tragicommedia dai tratti esasperati.
La trama, di per sé lineare, riflette su un tema molto attuale nel periodo di composizione dell’opera, in quanto con la fine del XX secolo si assiste al crollo delle grandi ideologie politiche e progressiste e al conseguente emergere, in tutte le tradizioni religiose, di una fede militante che ingaggia una lotta dalle proporzioni cosmiche tra forze del bene e forze del male. Come dimostrato da Norman Cohn in I fanatici dell’apocalisse (1965), molte di queste correnti sono legate al messianismo, termine con il quale s’intende “l’aspirazione a creare un ordine di cose preordinato, armonioso, perfetto, verso il quale gli uomini sarebbero irresistibilmente spinti e al quale devono necessariamente arrivare”, cioè realizzare il paradiso nella certezza che un giorno si stabilirà un’armonia perfetta in cui gli esseri umani vivranno completamente liberi da ogni condizionamento. Per poter parlare di messianismo l’idea di base è quella che la Storia si compia per promessa e volontà divina soltanto nell’ora che Egli ha deciso. Affinché questa convinzione diventi concreta è quindi necessario che l’uomo mobiliti tutte le proprie energie, fisiche e spirituali, al fine di conquistare la salvezza tra gli orrori del mondo. Orrori che portano a concepire la società come un campo di battaglia sul quale si svolgerà lo scontro finale tra eletti e dannati, scontro a cui Singer allude attraverso il suono dello shofar (Levitico 25,8-13; Esodo 19,20).
“Dovunque gli ebrei si divisero in due fazioni: i seguaci di Shabbatay Tzevi e i loro avversari. La controversia infuriava; ad ogni occasione le due sette si scomunicavano a vicenda col triplice rituale del corno d’ariete, della tavola di purificazione e delle candele nere. […] Profeti erranti e predicatori davano versioni personali della buona novella; fanatici di entrambe le parti si macchiavano di ingiustizie.” (p. 145)
Nell’ebraismo, di cui il messianismo è uno dei tratti costitutivi, la tradizione rabbinica ha sottolineato che l’avvento del Messia era stato fissato prima della creazione del mondo e fosse associato alla presenza di segni che permetterebbero di spiegare le catastrofi avvenute o annunciate. Non è un caso che nel Midrash Tehilim, salmo 45,3 appaia l’idea che il Messia sarebbe venuto in un’era di corruzione e colpevolezza: “Israele domanda al Signore: quando ci porterai la redenzione? Il Santo benedetto Egli Sia risponde: quando voi sarete discesi al livello più basso, in quel momento Io vi porterò la redenzione.” È dunque a questa affermazione che Singer si ricollega quando racconta le conseguenze sulla cittadina di Goraj della venuta di Shabbatay Tzevi e della creazione del movimento sabbatiano. L’evento catastrofico del 1648 aveva, infatti, permesso il rincorrersi in Polonia di strane dicerie basate sull’interpretazione della Cabbala e provocato il loro diffondersi attraverso l’arrivo di Reb Itche Mates e Reb Gedaliya, accolti dalla comunità con asservimento e devozione.
“I più grandi cabbalisti della Polonia e di altri paesi avevano scoperto nello Zohar e in altri scritti cabbalistici numerose allusioni comprovanti che i giorni dell’esilio erano ormai scontati. I massacri perpetrati da Chmel’nitskij erano le doglie che annunciavano la nascita del Messia. Secondo un calcolo segreto, tali doglie erano destinate a cominciare nell’anno 1648 e a continuare fino alla fine dell’anno in corso, quando sarebbe avvenuta la completa e perfetta redenzione.” (p. 24)
Secondo loro, Shabbatay Tzevi, ebreo orientale realmente vissuto, era il redentore tanto atteso: colui che, nel 1655 avrebbe attraversato il fiume Sambation e, giunto all’altra sponda, avrebbe preso in moglie la figlia del maestro Mosè “per condurre grandi guerre contro le nazioni della terra e rialzare la tenda caduta del re David”. Per realizzare ciò, secondo il movimento sabbatiano, era però necessaria una liberazione totale dai limiti imposti dalla legge ebraica, possibile solo attraverso una sistematica violazione di ogni precetto sacro e, dunque, attraverso il peccato: “Benedetto sia Colui che permette ciò che è interdetto”. Il bisogno di profanazione che ne deriva è ciò che muove l’agire della comunità di Goraj nell’anno 1666, indicato come il momento propizio per la redenzione dei figli di Israele, e che avrebbe dovuto accelerare la redenzione finale e il ritorno alla terra promessa. Accelerazione evidente anche dalla divisione in due parti del romanzo. La prima parte, di cui Rabbi Benish è il protagonista, mostra attraverso la narrazione della sua vita dall’esilio a Lublino al ritorno nella cittadina, l’evoluzione di Goraj come luogo un tempo dedito al rispetto della legge e dunque florido e il suo protendere verso un futuro di distruzione, tanto imminente da concludersi con la morte del rabbino. La seconda, invece, si concentra attorno alla figura di Reb Gedaliya, osservante del sabbatianismo e simbolo di una falsa prosperità. In questo contesto di trasgressione si profila la figura di Rechele, profetessa su cui si incentra la speranza della popolazione e a cui l’angelo Sandalfon rivela che le sue preghiere hanno penetrato i sette firmamenti e annuncia la completa redenzione per la comunità. Successivamente, Rechele, che è visitata ogni notte da angeli e profeti, riceve la notizia della conversione di Shabbatay Tzevi all’Islam e perde così il dono della profezia. A questo punto, coloro che, anche di fronte all’apostasia, rimangono fedeli al Messia si dividono in due fazioni e danno vita a una lotta tra sacro e profano, tra ascetici e libertini di cui Rechele è il fulcro. La donna, irretita dal profano, viene violentata e ingravidata da Satana, facendo finalmente aprire gli occhi agli abitanti dello shtetl. Nei due capitoli finali, infatti, la narrazione ha una svolta ammonitrice nei confronti della popolazione e descrive la purificazione di Rechele attraverso un esorcismo compiuto dal pio Reb Mordecai Yosef e il ritorno della comunità sulla retta via. Il profano è infine vinto, ma la lezione impartita, come si legge nella conclusione, è che “nessuno si attenti a forzare il signore a porre fine alle nostre pene in questo modo. Verrà il Messia al tempo da Dio designato, e libererà l’uomo da disperazione e peccato. Allora la morte riporrà la sua spada e Satana perirà aborrito ed esecrato. Lilit svanirà con la notte, l’esilio avrà fine e tutto sarà luce.” (p. 180).
Con Satana a Goraj, dunque, Singer non si limita a ricostruire le conseguenze dell’eresia sabbatiana ma esplora l’aspetto nefando del messianismo, attraverso un dipinto carnevalesco di orge, riti e ubriacature in grado di capovolgere il turpe in un glorioso trionfalismo. Trionfalismo che, attraverso l’espediente dell’ambientazione in una “città nascosta tra le colline in capo al mondo”, rivela le conseguenze di tutte quelle ideologie forvianti che dominavano gli anni Trenta del Novecento.
Bibliografia:
Ben Siegel, Isaac Bashevis Singer, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1969.
Ben Siegel, Sacred and Profane: Isaac Bashevis Singer’s Embattled Spirits, in “Critique: Studies in Contemporary Fiction”, 1963, vol. 6, n. 1, pp. 24-47.
Franco Palmieri, Isaac Bashevis Singer, Firenze, La nuova Italia, 1980.
Furio Biagini, Messianismo e desacralizzazione in “Satana a Goray”, in “La Rassegna Mensile di Israel”, 2005, Vol. 71, No. 2/3, pp. 151-160.
Isaac Bashevis Singer, Racconti, in Alberto Cavaglion (a cura di), Milano, Mondadori, 1998.
Isaac Bashevis Singer, Satana a Goraj, Milano, Adelphi, 2018.
Norman Cohn, Amerigo Guadagnin, I fanatici dell’Apocalisse, Torino, Einaudi, 2000.
Sandor Pinsker, “Satan in Goray” and the Grip of Ideas, in “Studies in American Jewish Literature”, 1981, n.1, pp. 14-23.
Apparato iconografico:
Immagine 1: https://www.adelphi.it/libro/9788845932663

